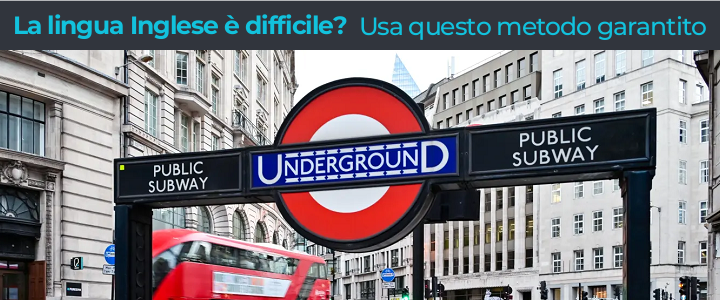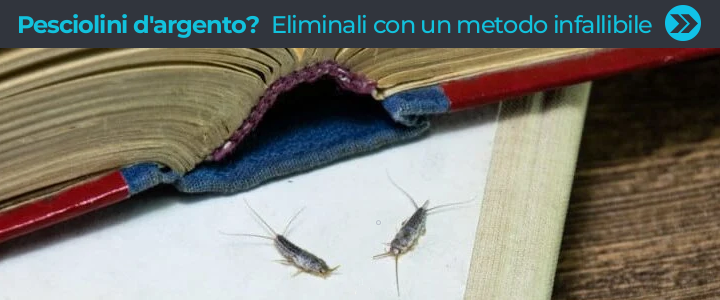Binari e Tratte Ferroviarie Dismesse in Emilia Romagna
La Ferrovia Rimini-Novafeltria nel territorio della Valmarecchia in Romagna

La linea ferroviaria Rimini-Novafeltria, nota anche come "Ferrovia della Valmarecchia", è stata una ferrovia a scartamento ridotto 950 mm che collegava la costa romagnola all'entroterra. Inaugurata nel 1922 e chiusa nel 1960, è stata fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della vallata, in particolare per il trasporto dello zolfo estratto dalle miniere di Perticara.
INDICE
LA FERROVIA RIMINI-NOVAFELTRIA: Un'Analisi Storica e Tecnica di un'Arteria Dimenticata della Valmarecchia
IL TRACCIATO DELLA LINEA
STAZIONI E FERMATE PRINCIPALI
IL MATERIALE ROTABILE: Dall'Epoca del Vapore all'Innovazione Diesel
LA GESTIONE DELLA LINEA
CHIUSURA DELLA LINEA: FATTORI TECNICI, ECONOMICI E SOCIALI
COSA RIMANE DELLA VECCHIA FERROVIA
CONCLUSIONI

LA FERROVIA RIMINI-NOVAFELTRIA: Un'Analisi Storica e Tecnica di un'Arteria Dimenticata della Valmarecchia
Inquadramento Storico e Geografico
La ferrovia Rimini-Novafeltria rappresenta un capitolo significativo, sebbene spesso trascurato, nella storia dei trasporti dell'Emilia-Romagna. Si trattava di una linea a scartamento ridotto di 950 mm, che per quasi mezzo secolo ha collegato la vitalità balneare di Rimini con l'entroterra montuoso del Montefeltro. Il suo percorso si estendeva per circa 34 chilometri, operando tra l'inaugurazione del 1916 e la definitiva chiusura nel 1960. Gestita inizialmente dalla Società Anonima delle Ferrovie e Tramvie Padane (FTP), passò poi sotto la Gestione Governativa Ferrovie Padane. Questa linea non era un semplice collegamento locale, ma un'arteria vitale che supportava lo sviluppo economico e sociale di un'intera vallata, la Valmarecchia.
Contesto e Obiettivi dell'Analisi
Il presente report si propone di offrire un'analisi approfondita di questa infrastruttura dismessa, andando oltre la mera cronologia per esplorarne le caratteristiche tecniche, il ruolo strategico, il materiale rotabile impiegato e le complesse ragioni che portarono alla sua chiusura. L'obiettivo è ricostruire la storia completa della ferrovia, dalla sua funzione cruciale nel trasporto di merci e passeggeri fino alla sua controversa dismissione, esaminando infine le tracce che essa ha lasciato nel paesaggio e nella memoria collettiva. Il report si prefigge di far emergere le dinamiche storiche e sociali che hanno determinato il suo destino, superando la narrazione convenzionale di una linea "non più necessaria".
Distinzione da Linee Contermini
Per una corretta comprensione, è fondamentale distinguere la ferrovia Rimini-Novafeltria da altre infrastrutture ferroviarie del territorio. In particolare, la linea non deve essere confusa con la coeva ferrovia elettrica Rimini-San Marino, che aveva un tracciato e una storia distinti. Sebbene entrambe collegassero la costa con l'entroterra, la linea per San Marino era una ferrovia elettrica e fu inaugurata nel 1932 , mentre la Rimini-Novafeltria era a vapore (e successivamente diesel) e fu aperta in due fasi, la prima già nel 1916. La loro coesistenza evidenzia la volontà di dotare la regione di una rete di trasporto capillare, sebbene con tecnologie e scopi specifici per ciascuna direttrice.
AD


IL TRACCIATO DELLA LINEA
Il tracciato della ferrovia si sviluppava per 33,2 chilometri, con una lunghezza totale, compreso il raccordo portuale, di 34 chilometri. Partendo dalla stazione di Rimini Centrale, il percorso volgeva verso sud-ovest, seguendo il corso del fiume Ausa e lambendo l'anfiteatro romano e le mura cittadine. Il percorso era un mix di lunghi rettilinei e ampie curve, affrontando un dislivello significativo di circa 256 metri tra la costa e la stazione di Novafeltria, che si trovava a 256 metri sul livello del mare. Lungo il tracciato, la linea attraversava la Via Flaminia tramite un unico passaggio a livello presidiato, mentre altri novanta passaggi a livello erano incustoditi.Caratteristiche Tecniche dell'Infrastruttura
La linea fu costruita con specifiche che riflettevano la sua natura di ferrovia secondaria e di montagna. L'infrastruttura utilizzava uno scartamento ridotto di 950 mm, diverso dallo standard di 1435 mm della rete nazionale. L'armamento era costituito da rotaie relativamente leggere, con un peso di 22,5 kg/m per 19.567 metri e di 25,5 kg/m per i restanti 16.059 metri. La pendenza massima era contenuta entro il 30 per mille, mentre il raggio minimo delle curve era di 70 metri.Queste caratteristiche tecniche, sebbene adatte all'esercizio con locomotive a vapore, limitavano la velocità massima ammessa a soli 40 km/h, un fattore che contribuì alla fama di lentezza della linea, tanto che il popolo la soprannominò "l'amaza sumer" (in dialetto romagnolo, "ammazzasomaro"). Il tracciato si sviluppava per 22,076 chilometri in sede promiscua, integrata con la viabilità stradale, e per 9,450 chilometri in sede propria, con un proprio sedime dedicato.
Il Raccordo con il Porto
Un dettaglio di notevole importanza logistica era il collegamento della ferrovia con il porto di Rimini. Un raccordo in sede stradale, lungo 1,797 chilometri, partiva dalla stazione di Rimini Centrale e raggiungeva il porto, evidenziando il ruolo integrato della linea nel sistema di trasporto regionale, che univa la ferrovia, la strada e il trasporto marittimo.
AD


STAZIONI E FERMATE PRINCIPALI
Il servizio ferroviario offriva una capillare copertura del territorio della Valmarecchia, con ben 16 fermate intermedie tra i capolinea. Le stazioni e le fermate servite dalla linea erano:
Rimini Centrale (Ferrovie Padane), Rimini Porta Montanara, Fornaci, Spadarolo, Vergiano, Casale Sarzana, Sant'Ermete, Corpolò, Villa Verucchio, Verucchio, Torello, Pietracuta, Bivio San Leo, Ponte Santa Maria Maddalena, Secchiano, Talamello-Campiano, Novafeltria (già Mercatino Marecchia). Molte delle ex stazioni sono ancora esistenti, riconvertite in abitazioni o altre strutture, e in alcuni tratti il vecchio sedime ferroviario è stato riutilizzato come percorso ciclo-pedonale.
Questo elenco esteso dimostra il profondo radicamento della linea nel tessuto sociale ed economico della vallata, fungendo da principale asse di collegamento per numerosi centri abitati.
AD


IL MATERIALE ROTABILE: Dall'Epoca del Vapore all'Innovazione Diesel
Inizialmente, l'esercizio della linea era a trazione a vapore. Successivamente, a partire dagli anni '50, vennero introdotte automotrici diesel (le cosiddette "littorine") per modernizzare il servizio e aumentarne l'efficienza. A causa della sua lentezza, era soprannominata scherzosamente dalla popolazione locale "l'amaza sumer" (l'ammazza somaro), poiché si riteneva fosse talmente lenta da non riuscire a travolgere nemmeno un asino.
L'Esercizio a Vapore
Nel corso della sua storia, la ferrovia ha visto l'utilizzo di diverse tipologie di mezzi di trazione. All'apertura della linea, e fino agli anni cinquanta, l'esercizio era affidato a locomotive a vapore. Il parco rotabili del 1933 era piuttosto eterogeneo e includeva due locomotive Breda da 160 kW, una Orenstein & Koppel da 120 kW e una più piccola Krauss da 55 kW, quest'ultima impiegata in precedenza sulla tranvia Ferrara-Codigoro. Oltre alle locomotive, il parco includeva carrozze a carrelli, bagagliai e numerosi carri merci per il trasporto di zolfo e altri materiali. Un pezzo di questa storia è stato conservato: la locomotiva a vapore Krauss è stata acquisita nel 1970 dal Chemin de Fer-Musée Blonay-Chamby in Svizzera, dove è stata restaurata ed è tuttora impiegata saltuariamente, fungendo da ponte tra la storia locale e il patrimonio ferroviario internazionale.
L'Introduzione delle Automotrici a Nafta
A partire dagli anni cinquanta, in un tentativo di modernizzazione e di aumento dell'efficienza, vennero introdotte automotrici diesel, comunemente note come "littorine". L'arrivo di questi nuovi mezzi, più veloci e affidabili rispetto al vapore, rappresentò un evento di grande risonanza, tanto da essere documentato in un documentario radiofonico del 1952 di Sergio Zavoli intitolato "Scartamento ridotto". Il documentario esplorava il dibattito tra la popolazione, divisa tra l'affetto per il vecchio treno a vapore e l'entusiasmo per la modernità rappresentata dalle automotrici.
Il Paradosso della Modernizzazione
L'introduzione delle automotrici a nafta ebbe un impatto immediato e misurabile sul servizio. Tra il 1951 e il 1956, il numero di passeggeri subì un'impennata, passando da una media di 18.000 a 45.000 al mese. Questo notevole incremento della domanda spinse a programmare anche servizi aggiuntivi sulla tratta più trafficata, quella tra Rimini e Villa Verucchio. I dati dimostrano chiaramente che la modernizzazione del parco rotabile aveva rivitalizzato la linea, rendendola un servizio di trasporto pubblico sempre più richiesto e funzionale. Questo quadro di successo, tuttavia, si scontra in modo palese con la decisione di chiudere la ferrovia solo pochi anni dopo, nel 1960. La chiusura non fu quindi motivata da una "crisi dei passeggeri" o da una linea in declino, ma da fattori esterni alla sua efficienza operativa.
AD


LA GESTIONE DELLA LINEA
La linea fu gestita dalla Società Anonima delle Ferrovie e Tramvie Padane (FTP), che in seguito divenne la Gestione Governativa Ferrovie Padane.
CHIUSURA DELLA LINEA: FATTORI TECNICI, ECONOMICI E SOCIALI
La ferrovia venne gravemente danneggiata durante la Seconda Guerra Mondiale. Sebbene fu parzialmente ricostruita nel dopoguerra, la sua soppressione avvenne per diversi motivi, tra cui la concorrenza sempre più forte del trasporto su gomma, che si stava espandendo e offriva maggiore flessibilità. L'invecchiamento delle infrastrutture e l'obsolescenza dei mezzi contribuirono a rendere la linea non più competitiva ed economicamente sostenibile. La sua chiusura definitiva, avvenuta nel 1960, segnò la fine di un'epoca per il trasporto ferroviario della Valmarecchia.
La Data e l'Esecuzione
La chiusura della ferrovia Rimini-Novafeltria, avvenuta nel 1960, si pone come un evento di notevole complessità e dibattito. La linea era gestita dal governo tramite la Gestione Governativa Ferrovie Padane , e la decisione di interrompere il servizio fu presa nonostante la dimostrata vitalità del trasporto passeggeri e merci. Il paradosso di una linea in crescita che viene smantellata suggerisce che le ragioni non fossero di carattere strettamente economico o funzionale, ma legate a una logica più ampia.
La Relazione del 1957 contro la Chiusura
Un documento storico di eccezionale importanza per comprendere le motivazioni è una relazione del 1957, redatta dall'allora direttore delle Ferrovie Padane, Bruno Bernardini, in cui si sollevava una ferma opposizione alla chiusura della linea. Questo testo, che circolò tra le autorità ministeriali, articolava argomentazioni di carattere tecnico, economico e sociale. Sul piano tecnico, si sottolineava che la ferrovia era l'unica via di collegamento sicura in una zona geologicamente instabile, soggetta a frane e smottamenti che rendevano la viabilità stradale costantemente precaria e pericolosa, soprattutto in inverno. Sul piano economico e sociale, la relazione affermava che la linea era vitale per le popolazioni del Montefeltro, e che la sua dismissione avrebbe arrecato un danno ingiusto e ingente alla comunità. L'opposizione alla chiusura era unanime e pubblicamente espressa da parlamentari locali, enti e popolazioni. Il fatto che una decisione di tale portata sia stata presa ignorando l'evidenza dei dati di crescita dei passeggeri e le argomentazioni locali sulla precarietà della viabilità stradale, suggerisce che la chiusura fu il risultato di una politica dei trasporti centralizzata. In quel periodo storico, si assisteva a un generale favore per lo sviluppo della rete stradale e del trasporto su gomma a scapito delle ferrovie secondarie. La storia della Rimini-Novafeltria diventa quindi un esempio emblematico di come le logiche di sistema a livello nazionale abbiano prevalso sulle esigenze specifiche e dimostrate di un territorio, declassificando e sacrificando un'infrastruttura di servizio in nome di una visione di mobilità standardizzata.
AD
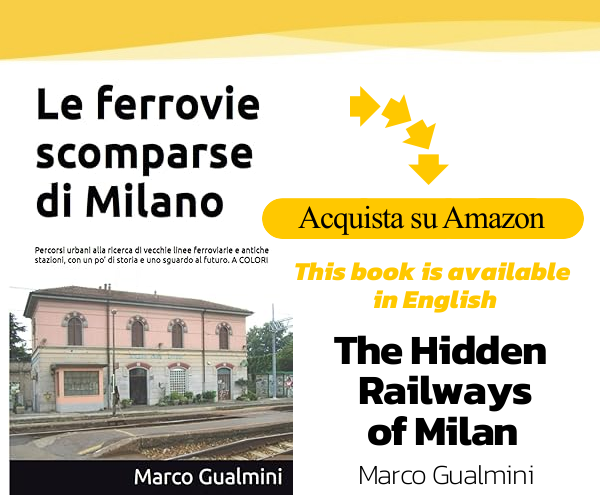

COSA RIMANE DELLA VECCHIA FERROVIA
Lo Smantellamento e l'Abbandono
Dopo la chiusura del 1960, la linea fu quasi interamente smantellata. Il sedime fu progressivamente abbandonato e le strutture, un tempo vitali, caddero in rovina. Molti viadotti, che avevano rappresentato un'importante opera ingegneristica, crollarono parzialmente. Il paesaggio fu così liberato da un'infrastruttura che aveva dominato per decenni, ma la sua memoria rimase impressa nel territorio attraverso le rovine e i resti ancora visibili.
I Resti e i Segni nel Paesaggio
Sebbene i binari siano stati smantellati, l'eredità della ferrovia persiste nel paesaggio e nell'urbanistica. Molti dei fabbricati delle ex-stazioni e fermate sono ancora visibili, benché in vari stati di conservazione. La loro trasformazione e il loro destino attuale riflettono le dinamiche socio-economiche che hanno interessato le località servite dopo la chiusura della linea. La stazione di Rimini Centrale (FP), ad esempio, è stata riutilizzata dalle autolinee sostitutive, così come l'edificio di Villa Verucchio. Un caso particolarmente emblematico è quello della ex-stazione di Verucchio, che è stata ristrutturata e convertita in un centro di ricerca delle Nazioni Unite, conferendole una nuova funzione di rilievo internazionale. Al contrario, altre strutture, come la fermata di Fornaci o la stazione di Dogana, sono in evidente stato di degrado o abbandono, pur conservando ancora il marciapiede originario. Il vecchio sedime ferroviario in alcune aree è stato inglobato nella carreggiata stradale, mentre in altre è stato riconvertito in percorsi pedonali o ciclabili. Il paesaggio stesso si configura come un "palinsesto storico", dove la struttura ferroviaria è stata sovrascritta da nuovi usi e trasformazioni, ma non è stata completamente cancellata. Le diverse forme di riuso dei fabbricati e del sedime riflettono il valore strategico che ogni località ha acquisito nel tempo, offrendo una mappa visiva della complessa eredità post-dismissione.
Lungo il percorso sono ancora visibili numerosi resti che raccontano la storia della linea. Alcuni ponti sono in buone condizioni e sono stati riutilizzati come percorsi pedonali , mentre altri viadotti rimangono in rovina, testimoni silenziosi del passato. La riattivazione della linea in chiave "dolce" crea un affascinante paradosso. La ferrovia, soprannominata "l'amaza sumer" per la sua intrinseca lentezza, fu chiusa a favore di un sistema di trasporto più veloce e incentrato sul trasporto su gomma. Oggi, la sua eredità rivive in un'infrastruttura che celebra proprio quella "lentezza" che un tempo ne era considerata il difetto principale. Il percorso, che prima era un mezzo per collegare due punti nel modo più affidabile possibile, è ora una risorsa per la contemplazione, il tempo libero e la riscoperta di un paesaggio ricco di storia. Questa trasformazione riflette un mutamento di valori sociali, in cui l'infrastruttura di trasporto non è più valutata unicamente in termini di efficienza economica e velocità, ma anche come un'opportunità di benessere e di riconnessione con il territorio.
La Nascita della Pista Ciclabile della Valmarecchia
In un'evoluzione sorprendente, una parte significativa del vecchio tracciato ferroviario è stata recuperata e trasformata in una pista ciclopedonale. Questo progetto di "mobilità dolce" ha ridato vita all'infrastruttura dismessa, convertendola da un'arteria di trasporto a un percorso ricreativo e turistico. La pista, che parte dal Ponte di Tiberio a Rimini e costeggia il fiume Marecchia, è adatta a tutti e si snoda in un percorso che unisce la natura, la storia e l'arte dei borghi fortificati della vallata. Il riutilizzo del sedime per la mobilità lenta è un esempio di come il patrimonio storico possa essere integrato in un nuovo modello di fruizione del territorio, in linea con le moderne tendenze di turismo sostenibile e consapevole.

CONCLUSIONI
Sintesi dell'Analisi
La ferrovia Rimini-Novafeltria, un'arteria a scartamento ridotto operativa dal 1916 al 1960, è stata un'infrastruttura di vitale importanza per il Montefeltro e la Valmarecchia. Progettata per collegare una zona geologicamente instabile con la costa, ha servito non solo le comunità locali ma ha anche sostenuto l'industria dello zolfo di Perticara. Il suo percorso, caratterizzato da un ingegneria adatta al territorio ma che limitava la velocità, è stato protagonista di un'evoluzione tecnologica, passando dalle locomotive a vapore alle automotrici diesel, un cambiamento che ha portato a un notevole incremento del numero di passeggeri negli anni Cinquanta. La sua chiusura, avvenuta nonostante l'evidente e crescente utilità, fu una decisione politica e di sistema, che ignorò le forti opposizioni locali e le argomentazioni legate alla stabilità del territorio.
Riflessioni Finali
La storia della ferrovia Rimini-Novafeltria è più di una semplice cronaca di un'infrastruttura dismessa; è un caso di studio che riflette le complesse dinamiche del Novecento italiano. La sua vicenda incarna il passaggio da un'economia locale, legata a risorse specifiche come lo zolfo, a una politica dei trasporti centralizzata che privilegiava la rete stradale. L'eredità della linea è un esempio tangibile di come le infrastrutture obsolete possano trovare una nuova vita: il vecchio sedime ferroviario, una volta simbolo di un progresso "lento", è oggi una pista ciclabile, un'infrastruttura di "mobilità dolce" che celebra la contemplazione e il contatto con la natura. I suoi resti, sparsi nel paesaggio e nei fabbricati riutilizzati, continuano a raccontare una storia di progresso, abbandono e rinascita, fungendo da memoria storica di un territorio e del suo profondo rapporto con le sue vie di comunicazione.
Torna all'Indice
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE LINEE PRESENTI IN QUESTA PAGINA:
Tracciato, Lunghezza, Scartamento, Trazione, Data di Apertura e Chiusura all'esercizio, Immagini, Approfondimenti e collegamento ai siti ufficiali.
TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
LINEE FERROVIARIE IN ESERCIZIO LINEE FERROVIARIE DISMESSE